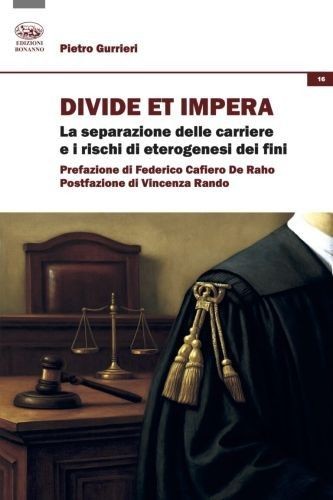Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Gratteri, un appello civile (e condivisibile) contro la normalizzazione del pubblico ministero
C'è una parola che ha attraversato, come una lama, l'intervento di Nicola Gratteri all'assemblea generale dell'Associazione nazionale magistrati: normalizzare. Ed è questa, più di ogni altra, la chiave per comprendere il senso profondo della sfida che oggi si gioca attorno alla separazione delle carriere. Perché dietro la pretesa di rendere "più efficiente" o "più imparziale" la giustizia penale come vorrebbe la retorica governativa e ministeriale, si cela - come ha denunciato il procuratore di Napoli - il disegno di "impaurire il pubblico ministero, di trasformarlo in un perfetto burocrate". Tesi che condivido, mi sentirei di dire, de plano e in toto, perchè emersa, in tutta la sua nettezza, dall'analisi scientifica che ha condotto al mio libro "Divide et impera: la separazione delle carriere e I rischi di eterogenesi dei fini", per i tipi di Bonanno.
Quello di Gratteri, però, è un allarme che non viene da un accademico - né da un politico - ma da chi la giustizia la abita da quasi quarant'anni, da chi ha conosciuto la solitudine delle indagini difficili e la forza corrosiva della delegittimazione. "Siamo rimasti soli, abbiamo lottato a mani nude", ha ricordato Gratteri, rievocando gli anni di Catanzaro. Eppure, quella solitudine non è mai degenerata in resa: è diventata testimonianza civile, presidio di indipendenza, atto di fede laica, si consenta questo termine ad un cattolico, nello Stato di diritto.
Oggi, quella stessa indipendenza è minacciata da un progetto di riforma che tende a recidere il filo sottile che tiene unita la magistratura: la comunanza nella giurisdizione, che è comunanza culturale e valoriale tra chi accusa e chi giudica. Separare le carriere non significa solo diversificare percorsi professionali, ma significa riscrivere la Costituzione materiale del processo, spezzare l'unità del potere giudiziario, aprire varchi all'esecutivo là dove la Carta repubblicana aveva posto argini invalicabili. Quando Gratteri parla di "normalizzazione", non evoca uno spettro astratto. Parla della tentazione, sempre ricorrente, di un potere politico che vorrebbe magistrati docili, prevedibili, gestibili: pubblici ministeri che "si guardino bene dal disturbare il manovratore". È la stessa logica che si intravede nella proposta di riformare, duplicandolo, il Consiglio superiore della magistratura, di introdurre il sorteggio - diretto e univoco per i magistrati, mediato però per i membri laici, per garantire ai politici spazi di manovra e, brutalmente, di prebenda - di comprimere gli spazi di autogoverno; di introdurre una Corte di giustizia dai contorni gravemente distonici rispetto ai principi costituzionali: un mosaico di interventi apparentemente tecnici che, messi insieme, disegnano un preciso orizzonte culturale – quello della magistratura subordinata.
Ma Gratteri non si è limitato alla denuncia. Ha lanciato un appello vibrante ai suoi colleghi: "Bisogna organizzarsi, parlare alla gente con i quattrocento vocaboli che le persone conoscono". È un invito alla militanza civile, alla discesa nella società reale, oltre le aule dei convegni e le liturgie degli addetti ai lavori. Perché la battaglia sulla giustizia, come quella sull'autonomia differenziata o sul premierato, non è una questione di tecnica, ma di democrazia. Ecco il punto decisivo: la riforma Nordio non è solo un intervento sull'ordinamento giudiziario, ma una svolta antropologica nella concezione stessa della funzione del pubblico ministero. Non più soggetto della giurisdizione, ma amministratore del penalismo di Stato; non più custode della legalità costituzionale, ma esecutore del potere politico. È alto, infatti, il rischio dell'eterogenesi dei fini di cui ho a lungo parlato nel mio libro, e che mi preoccupa ancor più del funzionariato o del servilismo, perchè anche questo può accadere, in un mondo che non è di santi. È questa la "normalizzazione" contro cui si leva la voce di Gratteri, ed è per questo che le sue parole scuotono, accendono, dividono. "Il coraggio non si vende al supermercato", ha detto con la consueta franchezza, replicando a chi - come il viceministro Sisto - ne aveva messo in discussione il comportamento per una partecipazione televisiva. Dietro quella battuta c'è un messaggio profondo: il coraggio, nella magistratura come nella società, non è virtù opzionale. È la condizione stessa della libertà.
Nel clima plumbeo di questi mesi, segnato da tentativi di riforma che minano i fondamenti costituzionali dell'indipendenza giudiziaria, l'intervento del procuratore di Napoli è risultato utile per ribadire che esiste - e non può essere soffocata dalla propaganda - una linea di demarcazione non solo tra modelli di giustizia, ma tra due idee di Repubblica: una che vuole una magistratura viva, critica, autonoma; l'altra che la vorrebbe pacificata, silenziosa, conforme. Gratteri sceglie la prima. E con lui, ad onta anche di quanto vogliano far credere le classi dirigenti dell'Avvocatura, moltissimi Avvocati e chi ancora crede che la giustizia non sia un mestiere, ma un dovere verso la verità. Perché, come insegnava Calamandrei "la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare". Ed è per questo che in tanti, indossando la Toga forense, sosterranno questa battaglia.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Informazioni sull'autore
Il mondo è la mia patria, e non a caso nulla c'è che mi emozioni quanto il viaggio e la scoperta di dimensioni, anche umane, accanto o al di fuori di me.
Solidarietà, pace, giustizia e rimanere umani ciò che più conta, odio i razzisti e, come Gramsci, gli indifferenti . Amo la mia famiglia, i miei amici, il cielo blu e l'arcobaleno.
Della prima parte della mia vita, ricordo mare, giochi e movimenti, poi una laurea in Giurisprudenza, qualche scuola di specializzazione e perfezionamento (impropriamente conferito ad un imperfetto per definizione e forse per scelta), l'esperienza di qualche anno in Università e CNR, prima di capire che volevo fare l'avvocato, qualche libro scritto tra una cosa e un'altra e, in ultimo, la straordinaria esperienza in Avviso Pubblico negli ultimi anni, tra impegno antimafia ed anticorruzione e costruzione di buone prassi nei territori.
Ultimi post dell'autore
Altri post dell'autoreUtilità
- Denaro, Tassi e Interessi, Contabilità famiglia e impresa
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI
- CALCOLATRICE INTERESSI MORATORI
- MODULO CREAZIONE RITENUTA D’ACCONTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
- CALCOLO DANNO PARENTALE
- CALCOLO DANNO BIOLOGICO
- CALCOLO USUFRUTTO
- CALCOLO INTERESSI A TASSO FISSO
- CALCOLO DEVALUTAZIONE MONETARIA
- CALCOLATRICE AUU (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE)
- CALCOLATRICE MUTUI
- CALCOLATRICE DANNO ECCEDENTE IN OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI E DI MORA IN ASSENZA DI TASSO (EX ART. 1284 CC)
- CALCOLATRICE DANNO NON PATRIMONIALE – TABELLE TRIBUNALI ROMA/MILANO
- CALCOLATRICE IMPORTO PENSIONE REVERSIBILITA’ E PENSIONE INDIRETTA
- CALCOLATRICE IMPORTI DA IMPOSTA IN REGIME FORFETTARIO
- Parcelle, Competenze, Onorari
- Processo, Termini, Scadenze
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO CIVILE
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO - MEMORIE E REPLICHE
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO ESECUZIONE
- CALCOLATRICE TERMINI IMPUGNAZIONE SENTENZE
- CALCOLATRICE TERMINI RICORSO CDS – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI CDS
- CALCOLATRICE TERMINI DEPOSITO CONSULENZE TECNICHE
- CALCOLATRICE C.U.
- CALCOLATRICE IMPORTI RILASCIO COPIE PROCESSO CIVILE
- PCT – MODULO CREAZIONE GUIDATA DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTI E ALLEGATI
- PCT – MODULO CREAZIONE GUIDATA ISTANZA VISIBILITA’ DEL FASCICOLO TELEMATICO
- CALCOLATRICE PENA DETENTIVA – AUMENTI E DIMINUZIONI
- CALCOLATRICE CONVERSIONE PENA DETENTIVA
- CALCOLATRICE TEMPO PRESCRIZIONE REATO
- Tutte le Utilità