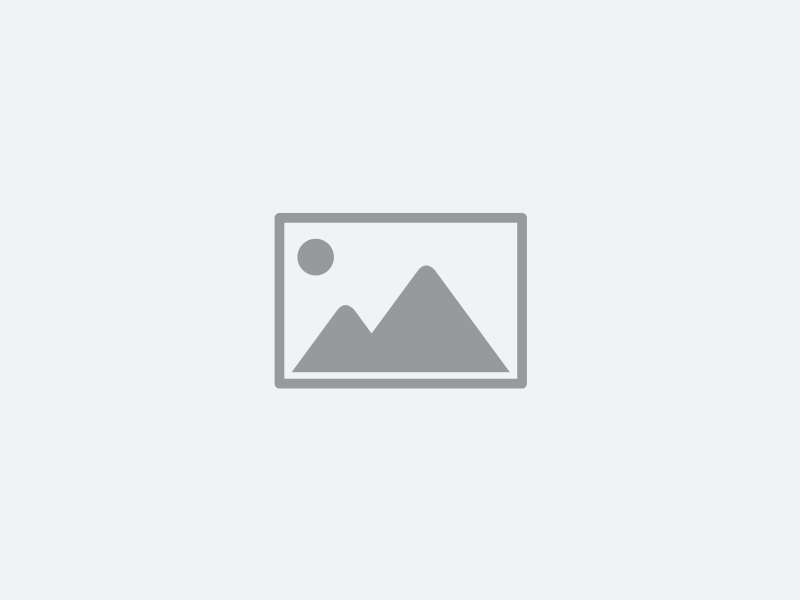Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Carneade, Cicerone nel De re publica: "Non esiste un criterio oggettivo di giustizia"
Originario del nord Africa e figura considerata minore fra i filosofi del suo tempo, è ricordato tuttavia come oratore appassionato (si dice dimenticasse di cibarsi per preparare i suoi lunghi discorsi tenuti in pubbliche piazze) e sottile dialettico.
Nel 155 a.C. Carneade fece parte, con Critolao e Diogene di Babilonia, della celebre ambasceria inviata a Roma dagli Ateniesi multati per aver saccheggiato Oropo; qui riscosse successo argomentando, in due giorni successivi, a favore e contro l'esistenza di una legge naturale universalmente valida. Le sue argomentazioni scettiche sulla giustizia scandalizzarono e sconvolsero gli ambienti della cultura conservatrice di Roma: egli affermava che se i Romani avessero voluto essere giusti avrebbero dovuto restituire i loro possessi agli altri e andarsene, ma in tal caso sarebbero stati stolti. In questo modo arrivò alla conclusione che saggezza e giustizia non andassero d'accordo. Così scrisse Cicerone nel De Re Publica:
«...ed espose tale tesi: tutti i popoli dominatori, innanzitutto i Romani capi del mondo, se avessero voluto essere giusti con il rendere le altrui proprietà, avrebbero dovuto ritornare come poveri alla vita nelle capanne» |
Fu uno scettico radicale e il primo filosofo a sostenere il fallimento dei metafisici che volevano scoprire un significato razionale nelle credenze religiose. Criticò lo stoicismo ad Atene e fu scolarca dell'Accademia platonica.
Carneade, pur ammettendo che niente può essere in senso assoluto criterio di verità, sosteneva l'impossibilità di conoscere, perché un essere umano, in quanto tale, sospende il giudizio su tutte quante le cose. A suo avviso infatti c'è differenza tra il "non evidente" e il "non comprensibile": infatti tutte le cose sono incomprensibili ma non tutte sono non evidenti. Questa distinzione, che tendeva a salvare in un certo modo l'evidenza del fenomeno, portò poi Carneade a stabilire comunque un criterio che se "non era vero" era però "probabile" (pithanon). I suoi critici, tuttavia, sottolineano come tendesse a mutare pensiero nel raggio di un breve tempo e anche per questa ragione, forse, il suo insegnamento è risultato piuttosto frammentato (oltre che per il fatto che non lasciò nulla di scritto, tanto che sarebbe poi toccato a un suo discepolo – Clitomaco, originario di Cartagine – esporne le argomentazioni nei propri scritti, peraltro andati perduti).
Carneade è conosciuto – e spesso nominato come sinonimo di persona poco nota – in ragione della celebre citazione contenuta ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nell'incipit dell'VIII capitolo, don Abbondio, uno dei personaggi principali del romanzo, è nella sua stanza che legge un panegirico in onore di San Carlo Borromeo, all'interno del quale è menzionato il filosofo. È a questo punto che esclama tra sé e sé la lapidaria battuta, destinata a diventare a suo modo famosa (e a condizionare molte biografie di personaggi considerati, appunto, dei "carneadi" per antonomasia): "Carneade! Chi era costui?".
Attraverso l'analisi di alcuni casi particolari, ripresi dalla tradizione sofistica e retorica, Carneade, qui raccontato da Cicerone, dimostra allo stupito ascoltatore romano l'impossibilità di risolverli in modo soddisfacente seguendo il criterio della giustizia oggettiva.
Cicerone, De re publica, III, 19-20
Allora lasciati i casi generali, veniva ai particolari. Egli dice: – Un galantuomo nel caso che possieda uno schiavo fuggitivo od una casa non igienica e dannosa alla salute, e nel caso che egli solo fosse al corrente di questi difetti ed annunziasse una vendita all'incanto, dovrebbe dichiarare di mettere in vendita uno schiavo fuggitivo od una casa insalubre, oppure dovrà tenerlo nascosto al compratore? Se lo dichiarerà, sarà considerato certo un galantuomo, perché non ingannerà, ma stolto, perché venderà per poco o non riuscirà a vendere affatto; se lo nasconderà, sarà saggio, perché farà il proprio interesse, ma anche disonesto, perché ingannerà.
Ed ancora, se si troverà qualcuno che crede di vendere del rame mentre si tratta di oro, o piombo invece di argento, il compratore farà finta di niente per acquistarlo a poco, o ne farà parola per comprarlo a caro prezzo? Certo sembrerebbe uno sciocco se preferisse acquistarlo a molto –. Dal che egli voleva far capire che il giusto ed onesto era stolto e disonesto il prudente; e che pure è possibile per gli uomini senza danno stare contenti della propria povertà.
Passava poi ad esempi piú gravi, secondo i quali nessuno poteva mantenersi giusto senza correr pericolo della propria vita; diceva infatti: è giustizia non uccidere il proprio simile e non toccare le cose altrui.
E che cosa farà allora un uomo giusto se in caso di naufragio uno piú debole di forze si sia afferrato ad un relitto galleggiante? non cercherà di farglielo lasciare per salirvi sopra egli stesso e scampare appoggiandovisi, specialmente se cosí in mezzo al mare non vi fosse alcun testimone? Se è prudente, lo farà, che, se non lo facesse, dovrebbe perder la vita; ma se scegliesse la morte anziché far violenza all'altro, sarà sí giusto, ma stolto perché non risparmia la propria vita per risparmiare l'altrui. Dal pari, sbaragliate le proprie schiere ed essendo già cominciato l'inseguimento da parte del nemico, questo uomo giusto imbattutosi in un ferito montato a cavallo, lo risparmierà per venire poi ucciso egli stesso, o lo sbalzerà dalla cavalcatura, per poter egli scampare al nemico? in questo secondo caso sarà stato saggio ma malvagio, giusto ma necessariamente anche stolto nel primo. Cosí dunque avendo distinto la giustizia in due parti, chiamando l'una sociale e l'altra naturale, le capovolge ambedue, dal momento che la prima è civile saggezza ma non vera giustizia, e la seconda è certo naturale giustizia, ma non saggezza. [...]
(Cicerone, Opere politiche e filosofiche, UTET, Torino, 1953, vol. I, pagg. 183-184)
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Informazioni sull'autore
Ultimi post dell'autore
Altri post dell'autoreForse potrebbero interessarti anche questi articoli
Utilità
- Denaro, Tassi e Interessi, Contabilità famiglia e impresa
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI
- CALCOLATRICE INTERESSI MORATORI
- MODULO CREAZIONE RITENUTA D’ACCONTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
- CALCOLO DANNO PARENTALE
- CALCOLO DANNO BIOLOGICO
- CALCOLO USUFRUTTO
- CALCOLO INTERESSI A TASSO FISSO
- CALCOLO DEVALUTAZIONE MONETARIA
- CALCOLATRICE AUU (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE)
- CALCOLATRICE MUTUI
- CALCOLATRICE DANNO ECCEDENTE IN OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
- CALCOLATRICE INTERESSI LEGALI E DI MORA IN ASSENZA DI TASSO (EX ART. 1284 CC)
- CALCOLATRICE DANNO NON PATRIMONIALE – TABELLE TRIBUNALI ROMA/MILANO
- CALCOLATRICE IMPORTO PENSIONE REVERSIBILITA’ E PENSIONE INDIRETTA
- CALCOLATRICE IMPORTI DA IMPOSTA IN REGIME FORFETTARIO
- Parcelle, Competenze, Onorari
- Processo, Termini, Scadenze
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO CIVILE
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO - MEMORIE E REPLICHE
- CALCOLATRICE TERMINI PROCESSO ESECUZIONE
- CALCOLATRICE TERMINI IMPUGNAZIONE SENTENZE
- CALCOLATRICE TERMINI RICORSO CDS – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI CDS
- CALCOLATRICE TERMINI DEPOSITO CONSULENZE TECNICHE
- CALCOLATRICE C.U.
- CALCOLATRICE IMPORTI RILASCIO COPIE PROCESSO CIVILE
- PCT – MODULO CREAZIONE GUIDATA DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTI E ALLEGATI
- PCT – MODULO CREAZIONE GUIDATA ISTANZA VISIBILITA’ DEL FASCICOLO TELEMATICO
- CALCOLATRICE PENA DETENTIVA – AUMENTI E DIMINUZIONI
- CALCOLATRICE CONVERSIONE PENA DETENTIVA
- CALCOLATRICE TEMPO PRESCRIZIONE REATO
- Tutte le Utilità